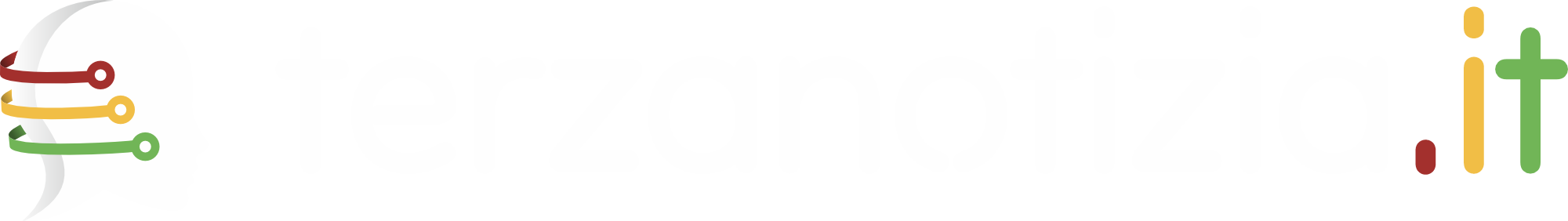The Dynamics of Sexual Attraction Across Real and Virtual Interactions: A Brief Journey Through Biology, Emotion, and Technology
Domenica Bruni[1]*
[1] Domenica Bruni è professoressa associata in Filosofia e teoria dei linguaggi presso l'Università di Messina. Si occupa di linguaggio, evoluzionismo e natura umana. Tra le sue pubblicazioni come autrice, Storia naturale dell’amore (Carocci, 2010), Politici sfigurati. Comunicazione politica e scienza cognitiva (Mimesis, 2012); Psicologia evoluzionistica. Dal cervello del Pleistocene alla mente moderna (Carocci, 2017) e, come curatrice, (con G.Ruggiero), Il ritmo della mente. La musica tra scienza cognitiva e psicoterapia (Mimesis, 2015); Like me? Mente e diritti negli altri animali (Novalogos, 2013); (con M.Ferraguti), Amor, c’ha nullo amato… amar bestiale (Graphe Edizioni, 2016). È vicepresidente della Società Filosofica Italiana – SFI (sezione di Palermo) ed è componente del laboratorio di Filosofia sperimentale presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina. ORCID: https://orcid.org/0009-0000-7974-8318
DOI: 10.82039/3103-165X-2025-3-BRUNIDOMENICA
PDF: https://terzanotizia.it/uploads/files/file_690c8867b89979-34650636.pdf
Abstract
Il contributo discute la continuità tra meccanismi biologici dell’attrazione e loro riformulazione in ambienti digitali. Visione, olfatto, segnali non verbali e processi neurochimici sostengono l’innamoramento nella presenza fisica, mentre le app e gli ambienti mediati dalla tecnologia spostano la seduzione verso curatela identitaria, algoritmi di selezione e comunicazione testuale o vocale. Ne emergono paradossi legati alla sovrabbondanza di scelta, all’idealizzazione dell’altro e al ghosting, ma anche nuove forme di intimità e narrazione del sé. L’argomento è trattato con fondamento evoluzionista e psicologico, mostrando come l’attrazione non venga annullata dal digitale, bensì tradotta in pattern espressivi differenti, dove la vulnerabilità rimane la condizione perché il desiderio si trasformi in legame autentico. Si suggeriscono implicazioni per educazione affettiva, alfabetizzazione digitale ed etica delle piattaforme.
Parole chiave: attrazione, ambienti digitali, antropomorfismo, algoritmi, vulnerabilità, intimità, evoluzionismo.
Abstract
The contribution explores the continuity between the biological mechanisms of attraction and their reformulation within digital environments. Vision, smell, nonverbal cues, and neurochemical processes sustain the experience of falling in love in physical presence, while apps and technology-mediated contexts shift seduction toward identity curation, algorithmic selection, and textual or vocal communication. This transition gives rise to paradoxes linked to choice overload, idealization of the other, and ghosting, but also to new forms of intimacy and self-narration. The topic is addressed from an evolutionary and psychological perspective, showing that attraction is not nullified by the digital dimension but translated into different expressive patterns, where vulnerability remains the condition for desire to evolve into an authentic bond. The work also outlines implications for affective education, digital literacy, and platform ethics.
Keywords: attraction, digital environments, anthropomorphism, algorithms, vulnerability, intimacy, evolutionary perspective.
Immaginiamo di tornare indietro di diecimila anni, in una radura sotto un cielo di stelle, con corpi che si annusano, si toccano, si osservano e si parlano. Nessuno smartphone, nessun filtro, nessuna possibilità di “swipe”. Solo esseri umani immersi nella loro fisicità e nella loro presenza reciproca. Ora torniamo al presente, davanti a una schermata di dating app, con una foto curata, una biografia di tre righe e un “match”. Segue una chat, qualche emoji, forse una videochiamata. È un salto di millenni, eppure non è un salto nel vuoto.
Ci troviamo in un cortocircuito evolutivo e culturale, dove un istinto antico - quello dell’attrazione romantica - incontra la potenza e le distorsioni del mondo digitale. Le dinamiche dell’attrazione, profondamente radicate nella biologia e nella storia dell’umanità, si trovano oggi a confrontarsi con ambienti artificiali, mediati da algoritmi, dove la percezione dell’altro è filtrata e ricomposta in modo nuovo.
L’attrazione romantica, nella prospettiva evoluzionista, si è sviluppata come un meccanismo biologico e psicologico volto a favorire la formazione di legami stabili e cooperativi tra individui. Questi legami hanno avuto un valore adattivo cruciale (Bruni, 2010; Buss, 1994; Fisher, 2004). La coppia stabile ha garantito la cura della prole, la condivisione delle risorse e la protezione reciproca. L’amore, in questa visione, non è un semplice stato emotivo, ma una strategia evolutiva che promuove la sopravvivenza e la trasmissione dei geni.
Tuttavia, questo antico istinto oggi si esprime in un contesto in cui molti dei suoi presupposti sensoriali sono mutati. Cosa accade all’attrazione quando non possiamo più “sentire” l’altro attraverso tutti i sensi, ma solo attraverso immagini, testo e voce? E, allo stesso tempo, quali aspetti di questo meccanismo restano invariati, anche dietro uno schermo?
Le radici biologiche dell’attrazione
L’attrazione è innanzitutto un fenomeno biologico complesso, che coinvolge molteplici sistemi sensoriali e neurochimici. Il nostro cervello valuta in frazioni di secondo una serie di segnali visivi e comportamentali come, ad esempio, la simmetria del volto, la postura, l’espressione e la qualità del movimento. Questi elementi sono correlati, sul piano evolutivo, a indicatori di salute, vitalità e fertilità (Langlois et al., 2000).
A questa dimensione visiva si intreccia quella olfattiva, spesso sottovalutata ma potentissima. Il celebre esperimento di Claus Wedekind (noto come “studio delle magliette sudate”) ha mostrato che gli esseri umani tendono a preferire inconsciamente l’odore di individui con un complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) diverso dal proprio (Wedekind et al., 1995). Tale meccanismo favorisce, dal punto di vista evolutivo, la generazione di una prole geneticamente più resistente alle malattie.
Sul piano neurobiologico, la cosiddetta “chimica dell’amore” si traduce in un insieme di processi ormonali e sistemi dei neurotrasmettitori. La dopamina, implicata nei circuiti della ricompensa, genera euforia, motivazione e desiderio; la serotonina regola l’umore e l’attenzione verso l’altro; l’ossitocina, nota come “ormone dell’attaccamento”, rafforza la fiducia e la connessione emotiva; l’adrenalina, infine, attiva la risposta fisiologica di eccitazione, producendo le ben note “farfalle nello stomaco” (Fisher, 2004). Queste sostanze interagiscono nel costruire un’esperienza che combina piacere, anticipazione e legame, dando forma al complesso fenomeno dell’innamoramento.
Anche il linguaggio corporeo gioca un ruolo decisivo. Gesti, postura, contatto visivo, intonazione e ritmo del parlare costituiscono un codice non verbale che trasmette disponibilità, interesse e affinità. Come mostrano gli studi di Mehrabian (1972), una parte significativa della comunicazione affettiva passa attraverso canali non verbali, che costruiscono la percezione di sintonia emotiva ben prima che le parole intervengano.
La dimensione temporale e relazionale dell’attrazione
Oltre ai fattori sensoriali e neurochimici, l’attrazione si sviluppa nella dimensione temporale della presenza e della reciprocità. La vicinanza fisica e il tempo condiviso favoriscono la familiarità e la fiducia. Questo meccanismo è stato descritto come “effetto di mera esposizione” (Zajonc, 1968), secondo cui la ripetuta esposizione a uno stimolo - o a una persona -tende ad aumentare il gradimento nei suoi confronti, purché l’esperienza sia positiva. La continuità e la reciprocità diventano, così, elementi centrali nella trasformazione dell’attrazione in legame. La presenza che si rinnova nel tempo, l’attenzione costante, la capacità di essere “disponibili emotivamente” costruiscono quella base affettiva che trasforma la passione iniziale in connessione duratura (Aron et al., 2005). In questo senso, l’attrazione non è solo impulso, ma un processo relazionale che si consolida nella quotidianità, attraverso gesti, sguardi e micro esperienze condivise.
Dal contatto alla connessione: l’attrazione nell’era digitale
Nelle relazioni mediate dalla tecnologia, molti di questi meccanismi biologici vengono ridefiniti. L’olfatto, il tatto e la prossimità fisica vengono sostituiti da immagini e testi, mentre l’attenzione e la dopamina si legano a dinamiche di gratificazione istantanea -notifiche, like, messaggi ricevuti - che riproducono, in forma sintetica, i circuiti del piacere (Alter, 2017). L’esperienza dell’attesa e della reciprocità è sostituita dall’immediatezza e la costruzione dell’immagine di sé e dell’altro passa attraverso una curatela intenzionale, una “messa in scena” identitaria.
Tuttavia, la tecnologia non annulla la natura dell’amore e dell’attrazione, ma ne ridefinisce il linguaggio. L’essere umano continua a cercare intimità, fiducia e riconoscimento anche attraverso media artificiali perché queste dimensioni rispondono a bisogni evolutivi profondamente radicati. La tecnologia, quindi, non sopprime l’amore, ma ne trasforma i percorsi espressivi, spostandoli dal corpo al simbolo, dal contatto alla connessione.
In fondo, restiamo esseri relazionali. Il bisogno di essere visti, toccati, ascoltati e riconosciuti rimane immutato, anche quando la mediazione digitale ne cambia la forma. L’attrazione, più autentica, quella che resiste al tempo e alle trasformazioni tecnologiche nasce ancora nello spazio della presenza, nella reciprocità, nell’impegno quotidiano di “esserci”. È lì che la biologia incontra la cultura e dove il desiderio, anche nell’era dei pixel, continua a parlare la lingua dell’umano.
Desiderio e identità nell’era digitale
L’era digitale ha trasformato radicalmente le modalità del desiderio e dell’incontro. Nelle app come Tinder o Bumble non ci sono odori né segnali corporei, nessun contatto fisico. Tuttavia, percepiamo attrazione, curiosità e connessione. È come se l’attrazione mutasse pelle e si trasformasse da fenomeno corporeo a narrazione progettata. Questo cambiamento non è solo logistico (passare dai bar alle chat), ma culturale, psicologico e sociale.
In passato, il caso, il destino o i luoghi frequentati erano i mediatori degli incontri; oggi sono gli algoritmi a mediare il primo contatto. Filtri automatici determinano chi ci viene mostrato, basandosi su preferenze, comportamenti e dati. In questo senso la tecnologia non è più strumento neutrale, ma agente attivo che orienta il desiderio, riduce o espande le possibilità e guida le scelte affettive, spesso senza che ne siamo consapevoli. Una dinamica, questa, confermata anche da Castro e Barrada (2020), che evidenziano come l’uso delle app di dating sia fortemente associato a variabili psicologiche e sociali legate alla ricerca di connessione, autostima e gratificazione immediata.
Nel contesto digitale, l’identità non è più una dimensione fissa ma un progetto narrativo. Profilo dopo profilo, post dopo post, scegliamo che foto mostrare, come formulare i messaggi, quali aspetti enfatizzare o nascondere. Questa costruzione del sé, insieme alla tendenza ad attribuire qualità umane a profili e avatar digitali, riflette ciò che Koike e Loughnan (2021) descrivono come antropomorfismo relazionale, un meccanismo attraverso cui gli individui instaurano legami emotivi autentici con entità virtuali. Ci presentiamo come versioni selezionate di noi stessi, cercando di mostrare non solo ciò che siamo, ma anche ciò che desideriamo apparire agli occhi degli altri. Questa costruzione del sé nasce dal bisogno di essere riconosciuti e accettati, e può diventare un processo consapevole, persino creativo, attraverso cui sperimentiamo nuove sfumature della nostra identità. Allo stesso tempo, però, può trasformarsi in una fonte di pressione sociale, spingendoci a mantenere un’immagine ideale che non sempre coincide con la nostra realtà interiore, generando così una dissonanza tra chi siamo davvero e come vogliamo essere percepiti. In assenza di sguardi, gesti e corpo, la seduzione si affida alla parola e alla voce. Un messaggio ben scritto, un’interruzione inattesa, una nota vocale possono suscitare emozioni profonde perché diventano i vettori principali dell’intimità. Tuttavia, tale situazione amplifica i rischi di fraintendimento dal momento che il tono si perde, le pause si fanno fredde e l’ironia si smarrisce. In questo contesto, la capacità di esercitare empatia digitale diventa fondamentale.
Nel linguaggio affettivo contemporaneo entrano emoji, meme, GIF, roleplay, ambienti virtuali: strumenti che arricchiscono la comunicazione con microsegnali, ironie condivise, paesaggi emozionali. Un meme può diventare codice affettivo, un avatar può incarnare affinità, un gioco online può ospitare relazioni autentiche. L’intimità diventa più ludica, modulare, ibrida, reale anche nella sua “apparente finzione”.
Paradossi dell’incontro digitale e il valore della vulnerabilità
L’attrazione digitale porta con sé alcuni paradossi. La scelta infinita è il suo maggiore rischio. L’“overchoice” o paradosso della scelta, già studiato da Barry Schwartz (2004), suggerisce che troppe opzioni non liberano, ma paralizzano (cioè, più scelta può significare minore soddisfazione).
Nel mondo degli incontri digitali questa condizione si manifesta in modo evidente, perché la possibilità di scorrere centinaia di profili con un semplice gesto offre un senso di libertà che però si accompagna a una crescente superficialità nelle scelte. La sovrabbondanza di opzioni tende a modificare il modo in cui le persone valutano i potenziali partner, spingendole a scartare in modo impulsivo e a investire meno tempo ed energia nel conoscere davvero qualcuno. Uno studio ha mostrato che, man mano che aumentano le alternative, i partecipanti rifiutano un numero sempre maggiore di candidati, con una diminuzione media del 27 % nella probabilità di accettare opzioni successive, un fenomeno definito “rejection mind-set” (Pronk & Denissen, 2020; Zandbergen, 2017).
Questa dinamica può essere interpretata come un effetto collaterale della logica di consumo applicata alle relazioni, in cui le persone diventano prodotti tra cui scegliere. Il desiderio di trovare il “match perfetto” si intreccia con la paura di fare una scelta “sbagliata”, portando molti a rimanere in una ricerca continua e insoddisfacente. Altri studi segnalano che un’ampia disponibilità di partner non aumenta la felicità, ma può al contrario alimentare la paura di restare soli, la sensazione di essere sopraffatti e una progressiva riduzione dell’autostima. Nel lungo periodo, questa dinamica rischia di trasformare l’esperienza dell’incontro in un processo di valutazione continua, dove la connessione autentica lascia spazio alla performance e al confronto incessante.
Un ulteriore aspetto riguarda il processo di idealizzazione, che negli incontri online si manifesta con particolare forza. Quando conosciamo qualcuno attraverso uno schermo, costruiamo la sua immagine a partire da pochi elementi: una biografia curata, alcune fotografie scelte con attenzione, poche frasi pensate per colpire. Questi frammenti diventano il materiale su cui la mente lavora, riempiendo gli spazi vuoti con aspettative, proiezioni e desideri personali. In assenza di segnali reali – il tono della voce, la gestualità, la presenza fisica – tendiamo a completare l’altro come vorremmo che fosse, attribuendogli qualità e significati che rispecchiano più i nostri bisogni che la sua reale personalità.
Quando la relazione passa dal mondo digitale a quello reale, questo castello di rappresentazioni può incrinarsi. L’incontro autentico, con la sua inevitabile complessità e imperfezione, mette alla prova l’immagine idealizzata che avevamo costruito. Ciò che prima appariva perfetto può rivelarsi contraddittorio o semplicemente diverso da come lo avevamo immaginato. Questa distanza tra aspettativa e realtà genera spesso disincanto, delusione e, in alcuni casi, una sensazione di perdita, come se l’altro avesse tradito un’immagine che, in realtà, non gli apparteneva mai davvero.
La comunicazione mediata è intrinsecamente povera di segnali contestuali; senza sguardi, gesti, modulazioni vocali, diventa facile fraintendere.
Una frase apparentemente neutra può essere fraintesa come critica e un semplice silenzio può essere percepito come un segnale di rifiuto o abbandono. Nelle interazioni mediate dallo schermo, l’assenza di elementi non verbali, come il tono della voce, lo sguardo o la gestualità, amplifica l’ambiguità e lascia spazio a interpretazioni soggettive, spesso guidate dalle proprie paure o aspettative. In questo contesto, la distanza fisica e la facilità di interrompere la comunicazione rendono il disimpegno più semplice e immediato. “Sparire” o, come si dice oggi, ghostare, diventa non solo possibile, ma quasi normalizzato, una scorciatoia per evitare il confronto diretto con il disagio, la delusione o la vulnerabilità.
Questo modo di chiudere le relazioni, senza spiegazioni né chiarimenti, ha però un impatto profondo sul piano emotivo. Chi subisce il ghosting si trova improvvisamente privato di senso, costretto a colmare da solo il vuoto lasciato dall’altro. La mente tende a cercare una spiegazione, spesso rivolgendosi contro se stessa, alimentando sentimenti di inadeguatezza, ansia e insicurezza relazionale. Allo stesso tempo, anche chi ghosta non ne esce illeso poiché il mancato confronto priva della possibilità di una crescita emotiva, rafforzando l’idea che il legame sia qualcosa di facilmente sostituibile. In questo equilibrio fragile tra presenza e assenza, il rischio è che la comunicazione digitale, pur così immediata e accessibile, finisca per rendere più difficile l’esperienza autentica dell’incontro e della responsabilità affettiva verso l’altro.
Eppure, nonostante tutto, ciò che accade nel digitale non è necessariamente superficiale o illusorio. Le ricerche mostrano che relazioni nate online possono essere paragonabili, in termini di intimità e stabilità, alle relazioni offline (cioè “tradizionali”). Le persone attribuiscono significato alle interazioni digitali, costruiscono narrazioni affettive, producono coerenza tra sé e l’altro. In studi qualitativi, le persone raccontano di “colmare il vuoto emotivo” attraverso la tecnologia, di dare senso e forma alle loro relazioni anche quando l’incontro fisico è rimandato.
Se è vero che l’attrazione è plastica ossia capace di trasformarsi, adattarsi e reinventarsi, la sfida sta nel riconoscere che i mezzi che usiamo non sono neutralmente trasparenti, ma modellano il modo in cui sentiamo, scegliamo e ci esponiamo. Dove mancano gli stimoli sensoriali, entra in scena la fantasia, la mente costruisce scenari emotivi che fondono realtà e desiderio. Questo arricchisce l’esperienza affettiva, ma anche la rende fragile, perché poggia su immagini parziali.
Dove non può parlare il corpo, la parola assume densità. Il messaggio diventa strumento di osservazione, di riflessione e di attesa. Ogni frase può essere riletta, custodita, interpretata. Se presente, la voce diventa carezza sonora, presenza, ancoraggio emotivo. La scrittura diviene linguaggio dell’intimità, lento e selettivo, capace di accendere legami profondi.
L’assenza della presenza immediata genera spazio d’attesa e, in quell’intervallo, si annida il desiderio. Quando non tutto è disponibile subito, l’attesa nutre la tensione, l’immaginazione e l’aspettativa. Il tempo tra un messaggio e l’altro acquista valore, la distanza diventa terreno fertile per l’attrazione.
Ma questa trasformazione non è neutra per la persona. Cambia la modalità dell’esposizione emotiva. Ci sentiamo più sicuri dietro uno schermo ma più vulnerabili quando chiedono di mostrarci per chi siamo davvero. Ci abituiamo alla gratificazione veloce, alla risposta pronta, all’efficienza comunicativa; fatichiamo a tollerare l’ambiguità, la lentezza, le imperfezioni. Esporsi, in un mondo pieno di filtri, cancellazioni e revisioni, è un atto di coraggio, perché la vulnerabilità diventa l’unica forma di autenticità possibile. Senza vulnerabilità, nessuna attrazione, per quanto intensa, può trasformarsi in un legame autentico e duraturo. L’attrazione, da sola, può accendere il desiderio e stimolare la curiosità verso l’altro, ma rimane confinata in una dimensione superficiale se non è accompagnata dalla capacità di mostrarsi per ciò che si è, con le proprie fragilità e imperfezioni. La vulnerabilità rappresenta la soglia attraverso cui l’incontro diventa reale: è il momento in cui si rinuncia al controllo dell’immagine e si permette all’altro di vedere anche ciò che solitamente si tende a nascondere.
Mostrarsi vulnerabili non significa debolezza, ma coraggio. Significa esporsi al rischio del rifiuto, accettare l’incertezza e la possibilità di essere feriti, ma anche aprirsi alla possibilità di essere compresi e accolti. Nelle relazioni contemporanee, spesso dominate dall’auto-presentazione e dal bisogno di apparire forti, indipendenti e desiderabili, la vulnerabilità diventa un atto controcorrente, una forma di autenticità che rompe le difese e permette una connessione più profonda.
Solo attraverso questa disponibilità reciproca ad abbassare le proprie barriere emotive l’attrazione può evolvere in intimità, fiducia e condivisione reale. È nella vulnerabilità che nasce la possibilità di costruire un legame che non si fonda soltanto sull’interesse o sulla passione momentanea, ma sulla conoscenza sincera dell’altro e sull’accettazione reciproca delle proprie umanità.
Oltre lo schermo: la continuità del desiderio umano
Oggi il confine tra reale e virtuale è sempre più sottile e sfumato, al punto che non si può più parlare di due mondi separati ma di dimensioni che si intrecciano, si influenzano e si contaminano continuamente. La vita digitale non è più un’estensione artificiale di quella reale, ma ne diventa una parte integrante, uno spazio in cui emozioni, relazioni e identità si plasmano e si riflettono a vicenda. Le nostre esperienze affettive non si dividono più in “vere” e “finte”, perché ogni forma di interazione, che avvenga di persona o attraverso uno schermo, contribuisce a costruire il modo in cui ci percepiamo e ci relazioniamo con gli altri.
Le relazioni contemporanee assumono così una natura ibrida e complessa, in continua trasformazione. Comprendere come l’attrazione si modifichi in questo nuovo scenario non è un esercizio puramente teorico, ma un percorso di consapevolezza che ci permette di osservare i nostri meccanismi più profondi, le paure di non essere abbastanza, il desiderio di essere riconosciuti e la ricerca di autenticità in un contesto che spesso privilegia l’apparenza. La tecnologia amplifica le possibilità di incontro, ma allo stesso tempo ci espone a nuove forme di vulnerabilità, in cui la connessione emotiva deve farsi strada tra filtri, algoritmi e aspettative digitali.
Al di là di ogni schermo, resta immutato il bisogno umano di connessione, quello di essere visti, scelti e desiderati per ciò che siamo. Che si tratti di uno sguardo fugace in metropolitana, di un messaggio inviato nel cuore della notte o di un avatar che ci sorride sullo schermo, ciò che cerchiamo è sempre la stessa scintilla: quel momento in cui l’altro ci fa sentire vivi, riconosciuti e, almeno per un istante, meno soli.
Riferimenti bibliografici
Abeliuk, A., Elbassioni, K., Rahwan, T., Cebrian, M., & Rahwan, I. (2019). Price of Anarchy in Algorithmic Matching of Romantic Partners. https://doi.org/10.1145/3627985
Alter, A. (2017). Irresistible: The rise of addictive technology and the business of keeping us hooked. New York, NY: Penguin Press.
Bruni, D. (2010). Storia naturale dell’amore. Roma: Carocci.
Buss, D. M. (1994). The evolution of desire: Strategies of human mating. New York, NY: Basic Books.
Castro, Á., & Barrada, J. R. (2020). Dating apps and their sociodemographic and psychosocial correlates: A systematic review. International journal of environmental research and public health, 17(18), 6500. https://doi.org/10.3390/ijerph17186500
Fisher, H. (2004). Why we love: The nature and chemistry of romantic love. Macmillan.
Hancock, J. T., Toma, C., & Ellison, N. (2007, April). The truth about lying in online dating profiles. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems (pp. 449-452). https://doi.org/10.1145/1240624.1240697
Koike, M., & Loughnan, S. (2021). Virtual relationships: Anthropomorphism in the digital age. Social and Personality Psychology Compass, 15(6), e12603. https://doi.org/10.1111/spc3.12603
Langlois, J. H., Kalakanis, L., Rubenstein, A. J., Larson, A., Hallam, M., & Smoot, M. (2000). Maxims or myths of beauty? A meta-analytic and theoretical review. Psychological bulletin, 126(3), 390-423.
Lomanowska, A. M., & Guitton, M. J. (2016). Online intimacy and well-being in the digital age. Internet interventions, 4, 138-144.
Mehrabian, A. (1972). Nonverbal communication. Chicago, IL: Aldine-Atherton.
Pronk, T. M., & Denissen, J. J. (2020). A rejection mind-set: Choice overload in online dating. Social Psychological and Personality Science, 11(3), 388-396.
Schwartz, B. (2004). The paradox of choice: Why More Is Less. New York, HarperCollins.
Toma, C. L., Hancock, J. T., & Ellison, N. B. (2008). Separating fact from fiction: An examination of deceptive self-presentation in online dating profiles. Personality and social psychology bulletin, 34(8), 1023-1036.
Wedekind, C., Seebeck, T., Bettens, F., & Paepke, A. J. (1995). MHC-dependent mate preferences in humans. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 260(1359), 245-249.
Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of personality and social psychology, 9(2p2), 1.
Zandbergen, E. (2017). The effects of too much choice and information in online dating website designs (Technological paradoxes in Marketing Communication) (Master's thesis, University of Twente).