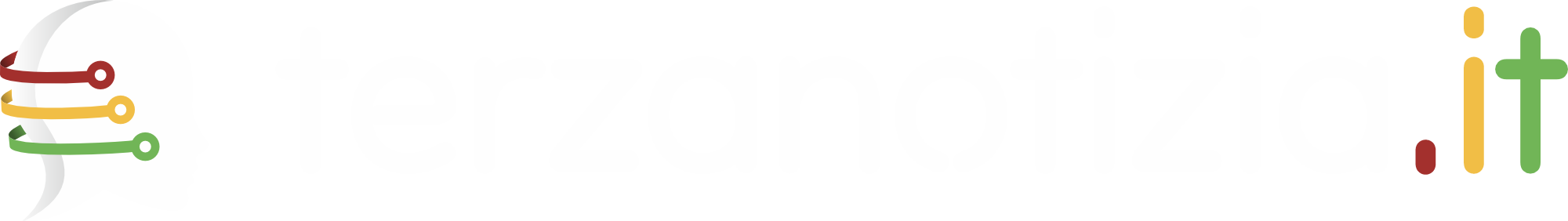L’arte è da sempre il linguaggio con cui l’uomo si interroga su se stesso. Oggi quelle domande passano attraverso il filtro nuovo e forse inquietante dell’intelligenza artificiale generativa. Immagini, testi, musiche create da algoritmi popolano gallerie, riviste e piattaforme online.
Ma cosa stiamo guardando davvero? È ancora arte o una statistica travestita da creatività?
I sistemi generativi funzionano rielaborando miliardi di dati, fotografie, dipinti, scritti, melodie. Non inventano, ricombinano. L’effetto è sorprendente e così si genera un'immagine che sembra dipinta da un maestro impressionista, una poesia che evoca il tono di un classico, una melodia che richiama Bach. Eppure dietro c’è un semplice calcolo di probabilità.
L’atto creativo umano nasce dal corpo, dal vissuto, dall’esperienza del dolore o della gioia. Un algoritmo può riprodurre lo stile, ma non lurgenza che lo ha generato.
Chi è l’autore di un’opera prodotta dall’IA? Il programmatore, il modello, il dataset di milioni di artisti anonimi che hanno contribuito involontariamente con le loro opere? La questione non è solo legale, ma etica. Parlare di creatività artificiale significa accettare che il concetto stesso di autore venga svuotato della sua identità per essere trasformato in un atto collettivo e impersonale.
L’opera dunque può essere prodotta in una infinità di combinazioni, ma priva di scarsità e di aura. Viene da chiedersi allora se ci troviamo di fronte ad una inedita declinazione di quel fenomeno che Walter Benjamin definì L'opera d'arte nel tempo della sua riproducibilità tecnica o semplicemente in un loop pseudo estetico, che castra la prerogativa dell'arte di rompere gli schemi, per offrire al suo posto un eterno dejàvu.
Ogni algoritmo porta con sé i limiti del dataset su cui è stato addestrato. Così anche l’arte generata riflette pregiudizi, stereotipi, visioni culturali parziali. Un modello che ha visto perlopiù volti occidentali produrrà ritratti che escludono altre etnie. Uno addestrato su immagini commerciali tenderà a privilegiare estetiche patinate e omologate.
L’IA generativa dà l’impressione di un mondo senza limiti, una vertigine di onnipotenza creativa dove basta un prompt per dare vita ad un’opera. Ma è proprio lì dove tutto può essere prodotto all’istante, che l’arte perde il suo valore simbolico, che nasce proprio dal tempo, dalla fatica, dalla scarsità.
La domanda che resta sospesa è se stiamo entrando in un’epoca di arte industriale, dove il gesto umano diventa marginale e la macchina assume il ruolo di artista seriale.
E tuttavia, l’IA può essere strumento, amplificatore, stimolo, può suggerire combinazioni, fornire spunti visivi, generare materiali di partenza che un artista umano rielabora e in questa prospettiva l’IA non sostituisce, ma collabora.
La sfida dell'arte è quella di mantenere chiaro il confine, ricordare che la creatività autentica non è solo risultato, ma processo, relazione, incarnazione di un vissuto e che nessun algoritmo, per quanto sofisticato, potrà mai provare la necessità interiore che spinge un essere umano a creare.
L’arte prodotta dall’intelligenza artificiale è specchio dei nostri tempi, affascinante e inquietante, ma se è veo che l’arte è il modo in cui l’umanità parla a se stessa, allora rinunciare a quel dialogo per affidarlo a una macchina significherebbe ridurre l’atto creativo ad una sterile eco di ciò che siamo già stati.